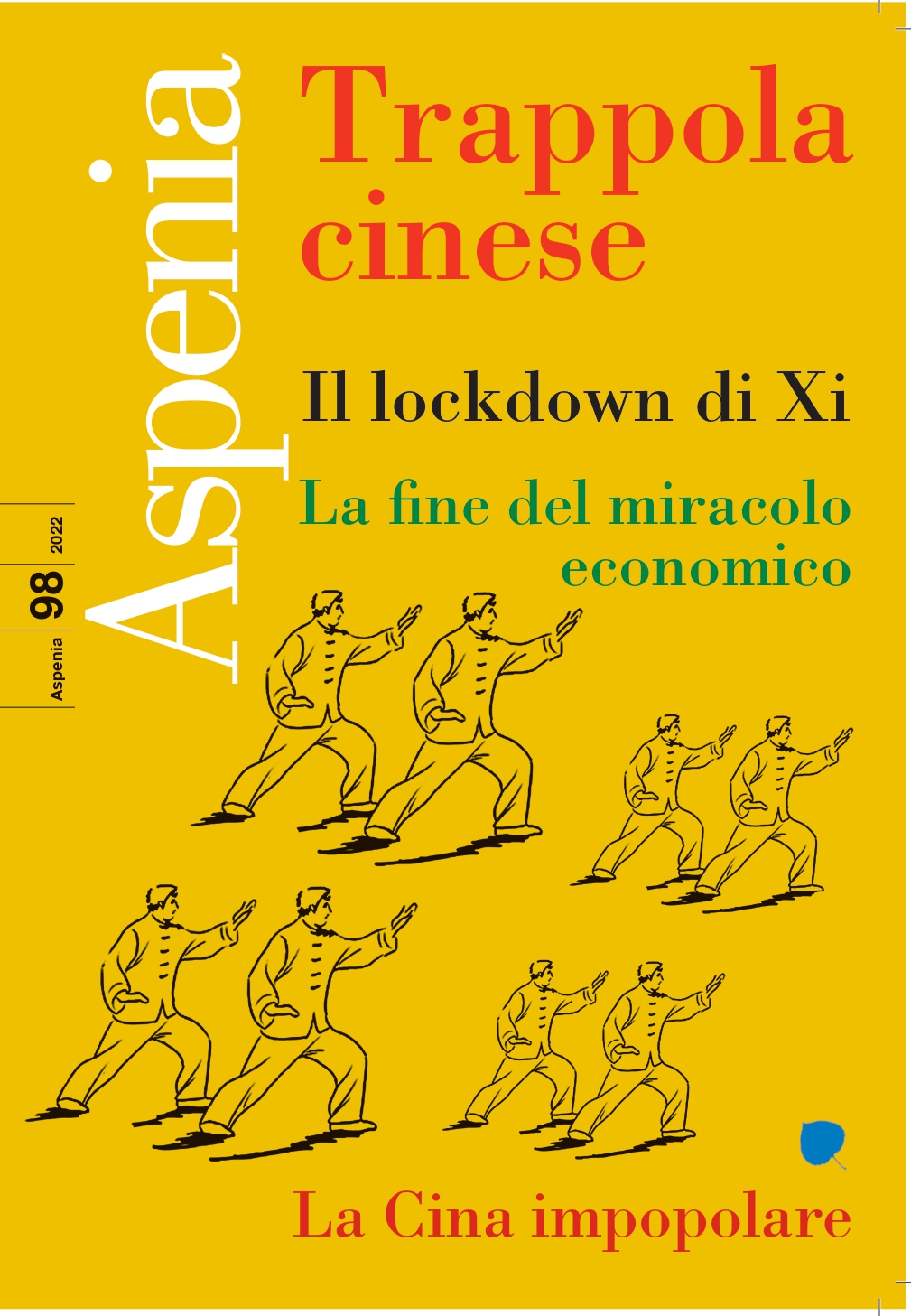Il Long Covid della Cina
Editoriale del numero 98 di Aspenia
L’investitura del XX Congresso del Partito comunista cinese, con Xi Jinping al suo terzo mandato, è stata preparata da epurazioni interne, da forzature ideologiche e da un nuovo tasso di nazionalismo. E avviene – cosa che potrebbe complicare i piani del nuovo imperatore rosso – in un momento quanto mai delicato per il sistema politico ed economico del paese.
La Repubblica popolare ha ormai acquisito il ruolo di grande potenza su scala globale, perlomeno nel senso che il suo impatto “sistemico” è ormai innegabile. Eppure, proprio nel momento in cui la Cina è in grado di esercitare un’influenza senza precedenti, emergono i vincoli e i limiti del suo modello di crescita: siamo alla fine del miracolo cinese per come lo abbiamo conosciuto negli ultimi decenni?
La strettoia più nota è la famigerata “trappola del reddito medio”, aggravata da un vero e proprio inverno demografico del paese. La Cina deve riuscire a consolidare i frutti dell’industrializzazione per passare a una vera economia post-industriale, basata anche e in modo crescente sulla domanda interna. Fare questo salto – nell’epoca di una parziale “de-globalizzazione” dell’economia internazionale, da cui la Cina aveva tratto forti vantaggi – non sarà facile per Pechino. Per le ragioni spiegate in molti dei saggi che pubblichiamo, le strategie economiche di Xi Jinping non riescono a ottenere i risultati sperati: la bolla immobiliare è forse l’indice più chiaro e concreto dei problemi che sta incontrando il paese.
Leggi anche: Contraddizioni cinesi
Ma questa prima trappola ne crea una seconda: il regime cinese, dopo decenni in cui la rapidità dello sviluppo economico è riuscita a legittimare il potere politico del PCC, rischia di perdere il famoso “mandato del cielo”. Nel senso che il vecchio trade-off fra benefici economici e rinuncia ai diritti politici, sembra meno solido di un tempo. Il XX Congresso, con la centralizzazione del potere nelle mani di Xi, appare in questo senso come una soluzione provvisoria, che copre ma certo non elimina forti tensioni nel gruppo dirigente cinese.
Il quadro economico, si diceva, è in netto rallentamento, per la prima volta dal 1980 e fatta eccezione per l’anno del Covid, il 2020. Se la Cina aveva reagito più rapidamente delle economie occidentali allo shock della pandemia, oggi si trova in condizioni non facili: il tasso di indebitamento, la crisi del settore immobiliare, la paura di una trappola ulteriore, quella della liquidità, sono tutti segnali preoccupanti.
Le ragioni per cui il modello cinese avrebbe prima o poi incontrato i suoi limiti erano state in parte previste. Come spiegano gli stessi economisti cinesi più attenti e intellettualmente aperti (a cominciare da Fu Jun, che scrive in questo numero di Aspenia), il paese ha superato la fase di crescita economica accelerata sfruttando fino in fondo la combinazione dei fattori di produzione, ovviamente in modalità cinese: capitali allocati quasi esclusivamente dal Partito-Stato, ampia manodopera a basso costo, tecnologie in buona misura importate o “clonate”. Con un fattore aggiuntivo essenziale: l’accesso ai grandi mercati globali, avvenuto – dall’ingresso nel WTO in poi- in modo non simmetrico. È stato un processo concentrato nel tempo, che ha consentito il più grande e rapido fenomeno di riduzione della povertà nella storia umana. Tuttavia, raggiunto lo stadio di economia “emersa” e creata una classe media, si impongono scelte non facili, perché l’attuale architettura istituzionale cinese non è certo l’ideale per gestire (senza soffocarli in nome del controllo diretto del Partito) la finanza, le aziende più innovative del digitale e settori industriali che per essere minimamente efficienti devono contare sui segnali del mercato.
Si può aggiungere un dato abbastanza ovvio. Senza le strutture di un vero Stato di diritto, i rapporti economici finiscono per essere subordinati a una volatilità di tipo specifico: quella delle lotte politiche interne, dei personalismi, degli slogan imposti dal vertice che diventano obiettivi arbitrari sconnessi da qualsiasi relazione domanda/offerta. Le distorsioni che ne derivano sono evidenti nella gestione della pandemia e prima ancora della sfida demografica. Tutti casi in cui una linea politica scelta in un dato momento – nel caso più recente il lockdown di grandi città, con le sue conseguenze economiche – è diventata quasi immutabile, nonostante moltissimi indicatori segnalassero forti rischi in arrivo. Il pragmatismo che viene spesso attribuito alla leadership cinese – a ragione in alcune fasi della storia contemporanea della Cina, assai meno in altre – non basta insomma a compensare le rigidità di un sistema decisionale e burocratico pensato per privilegiare il controllo verticale del Partito. E la non fallibilità del suo leader.
L’effetto complessivo di questo assetto è che, messa di fronte a problemi ricorrenti, la leadership di Pechino ricorre a strumenti autoritari e spesso coercitivi: lo si vede con Hong Kong, soffocata anche contro gli interessi del sistema finanziario e tecnologico cinese; e lo si vede con la questione delle minoranze (a cominciare da uiguri e tibetani), schiacciate per il timore atavico di qualsiasi compromesso che possa indebolire il centro rispetto alle immense periferie.
Con lo stesso metodo Pechino cerca di guidare i complicati processi di cambiamento tecnologico, sfruttando ogni sensore o telecamera come strumenti di monitoraggio della popolazione da parte delle autorità; ma uno Stato di polizia digitale non è compatibile con la creatività che si accompagna all’economia postindustriale.
Per semplificare al massimo il dilemma attuale: la Cina sembra da anni alla ricerca spasmodica di una sua “via” tra le libertà intese in senso occidentale (aborrite) e una visione centralizzata e pianificata della società (riconosciuta come non efficiente). Ma questo compromesso sfugge sempre di mano, e al momento della verità Xi non sembra avere in mano ricette innovative: con buona pace del pensiero “asiatista-confuciano” alla Kishore Mahbubani, o delle interpretazioni “tecnocratiche” di Parag Khanna (pur interessanti per molti aspetti), costruire un’alternativa al pacchetto democratico-liberale di mercato resta molto difficile.
In sostanza, il caso della Cina tende ormai a confermare che nessuna tecnocrazia autoritaria, per quanto pragmatica, riesce poi a combinare crescita economica e legittimità popolare in modo continuativo: le fasi di rallentamento economico tendono a generare una centralizzazione ulteriore del potere, con i suoi riflessi negativi per la gestione dell’economia. La trappola delle trappole: il Congresso di questo ottobre 2022 sembra confermarlo.
Tutto questo rischia di ridurre, invece che aumentare, le opzioni disponibili. Si vuole favorire la crescita ma intanto si indeboliscono i grandi innovatori digitali e si aumenta il perimetro delle aziende di Stato, comprimendo il settore privato; si vuole aumentare la competitività nell’hi-tech ma intanto si reprimono la libertà di sperimentazione e i contatti con l’esterno; si vuole migliorare la qualità del welfare state a scopo di maggiore equità ma intanto si punta tutto su vaccini made in China che non funzionano e costringono a ricorrenti lockdown. I nodi politici stanno venendo al pettine per l’economia e la società, mentre la iper-personalizzazione di Stato e Partito attorno alla figura di Xi rischia paradossalmente di evidenziare proprio le debolezze del nuovo imperatore – come scrive per Aspenia Cai Xia, ex professore della Scuola centrale del Partito oggi in esilio.
Su questo sfondo, quella che agli occhi esterni appare come un’ossessione con i durissimi lockdown per frenare le ondate di Covid è piuttosto la naturale conseguenza dell’approccio sopra descritto: l’intervento coercitivo riflette la sfiducia (reciproca) tra autorità e cittadini, cioè la mancanza di legittimità reale. Il governo centrale non si fida neppure delle autorità locali, abituato com’è a imporre la sua volontà a recalcitranti leader di partito che magari un giorno potrebbero diventare avversari politici. E intanto il sistema sanitario non può reggere l’urto di grandi focolai pandemici, che vanno dunque prevenuti a tutti i costi. Letteralmente: a qualsiasi costo per l’economia ma anche per le più elementari libertà personali.
Leggi anche: Il rischio di un precipizio cinese: lockdown anche oltre il Covid
Questa opzione coercitiva e centralistica, che Pechino sta utilizzando in modo sistematico da quasi tre anni, non è un punto di forza del modello cinese, ma piuttosto l’ammissione implicita del fatto che non ci sono alternative per una società complessivamente meno resiliente di quanto sembri.
La trappola dei lockdown è, in estrema sintesi, una grande metafora di una tendenza generale: la Cina deve rallentare perché non può permettersi di correre alla velocità che vorrebbe.
* * *
A cavallo tra la dimensione interna e quella internazionale, c’è un altro meccanismo che sta mettendo in trappola la seconda economia del pianeta: è la strada bloccata delle nuove Vie della Seta, o Belt and Road Initiative – di cui scrive su questo numero Thomas Duesterberg. Pechino ha scommesso moltissimo su una combinazione favorevole che prevede l’accesso ai maggiori mercati globali (che Pechino ha efficacemente sfruttato trasformandosi in uno snodo indispensabile della logistica oltre che della produzione) e al tempo stesso un graduale spostamento degli investimenti verso il proprio mercato interno. Il guaio è che il contesto internazionale è diventato sempre meno “benigno” anche per colpa della Cina stessa, della sua politica estera assertiva e dei suoi metodi ricattatori nei confronti dei partner della BRI. L’uso della leva del debito è un chiaro segnale in questo senso.
Come mostrano i sondaggi a cura del Pew Research Center che pubblichiamo su questo numero, la Repubblica popolare è diventata di conseguenza sempre più impopolare all’estero, e perfino quando viene apprezzata come partner commerciale viene ormai criticata e stigmatizzata come regime politico. I riflessi si vedono: a prendere atto di un clima certamente mutato, assai meno “business friendly”, è ad esempio la Camera di Commercio dell’Unione Europea a Pechino, che nel suo “Position Paper 2022-2023” constata un aumento dei rischi per gli investitori e prevede una fase di disinvestimenti. Insomma, la fiducia del business internazionale nei confronti del modello cinese è già in drastico calo.
È il risultato di scelte specifiche. Xi Jinping ha spinto chiaramente sul tasto del nazionalismo autoritario, scaricando le tensioni interne al paese verso questioni identitarie come quella di Taiwan o delle minoranze centroasiatiche. Il risultato è che Pechino ha avviato centinaia di progetti infrastrutturali mastodontici, in patria e in giro per il mondo, i quali ora sono un costo finanziario invece che una fonte di introiti. Ma se l’economia viene piegata agli obiettivi della politica di potenza (e della repressione interna), allora il dinamismo del modello cinese rischia di fermarsi. Se ciò avviene (e forse è già avvenuto), si disgrega il patto sociale intergenerazionale che ha retto la Repubblica popolare dagli anni delle riforme di Deng Xiaoping: in breve, le condizioni di vita devono continuare a migliorare in modo tangibile affinché il dissenso sociale e le divergenze interne a un paese vastissimo non sfocino nella contestazione politica.
Leggi anche: I costi economici del potere accentrato: l’era di Xi
Se questa trappola dovesse mai scattare, davvero la leadership comunista si troverebbe di fronte una minaccia esistenziale.
* * *
Ammettiamo che questi trend si stiano consolidando: dobbiamo allora prepararci a “contenere”, o tenere a distanza, una Cina insicura ma nazionalista e magari apertamente aggressiva su Taiwan? In parte ciò sta già accadendo, soprattutto da parte americana, ma quello militare e di sicurezza è solo un aspetto del quadro complessivo: il ruolo cinese nel futuro dell’economia globale è realmente un fattore chiave, che limita le opzioni (troppe costose anche per le economie occidentali) di un brutale e completo “decoupling”.
In questo senso, l’interesse occidentale non è che la Cina si blocchi in quanto “fabbrica del mondo”; è invece auspicabile che cambi il suo modo di fabbricare. In altre parole, motivazioni di sicurezza e priorità economiche si combinano, sia da parte cinese che da parte occidentale. E le due parti, per ora almeno, tentano di controllare i rischi di escalation, cioè quella particolare trappola piscologico-militare che è nota come “dilemma della sicurezza”. Siamo in effetti, mentre la guerra calda di Putin infiamma l’Ucraina, in una fase in cui né i paesi occidentali né la Cina intendono realmente entrare in una nuova “guerra fredda”.
Va in questa direzione la scelta, tutto sommato assai prudente, compiuta da Pechino rispetto alla guerra russo-ucraina – che la reazione occidentale e le sanzioni incrociate hanno trasformato in una prova di forza anche sulle regole del sistema globale. È parso chiaro, dopo le primissime battute, che Xi non farà alcun sacrificio – finanziario o politico, tantomeno militare – per aiutare Vladimir Putin a uscire dall’angolo in cui si è cacciato. Pechino ha interesse a limitare le capacità di influenza di Washington nella regione asiatica del Pacifico. E come Mosca punta a riscrivere, a suo vantaggio, gli equilibri del sistema internazionale.
Ma la partnership in teoria “senza limiti” con la Russia ha, dal punto di vista cinese, limiti invece molto netti. Sia perché Mosca è al massimo considerata un “junior partner” da Pechino.
Leggi anche: Russia-Cina: una frontiera problematica e un rapporto squilibrato
Sia perché la grande potenza asiatica intende sfruttare i vantaggi che possono derivarle dalla crisi in Ucraina (l’acquisto di petrolio a costi ridotti, le future forniture di gas) o può avere interesse a tenere gli Stati Uniti impegnati sul fronte europeo; ma non intende rischiare sanzioni secondarie o mettere in discussione più di tanto una stabilità internazionale a cui si collega lo sviluppo economico della Cina. Non a caso, i rapporti bilaterali con Washington non si sono interrotti, perfino a seguito della grave crisi estiva su Taiwan: Biden e Xi si considerano reciprocamente controparti difficili ma indispensabili, per cui il dialogo a tutti i livelli ha tuttora senso. La realtà dell’interdipendenza economica rimane forte, e il marcato rallentamento della crescita cinese consiglia a Pechino una certa prudenza nel far tremare le fondamenta della rete globale di scambi.
* * *
Esistono, in realtà, spinte contraddittorie su entrambi i lati del Pacifico. Da parte americana, alcuni settori della business community hanno scommesso fortemente sulla Cina come partner di lungo termine, come hub della logistica e produttore di beni intermedi; ma l’apparato militare è ormai nettamente orientato a confrontare la minaccia cinese come sua principale missione, e il Congresso tende a sottolineare anche gli aspetti ideologici (democrazia vs autocrazia) della contrapposizione sino-americana. Gli Stati Uniti di Biden hanno abbandonato la retorica di Trump sull’America assediata da avversari e alleati, ma non hanno rinunciato a varie misure protezionistiche e contano (fin dagli anni di Obama) su una sostanziale autonomia energetica, che non è certo poca cosa di questi tempi.
Da parte cinese, la linea ufficiale è ancora una difesa a oltranza della globalizzazione e dei mercati aperti (sebbene nel modo asimmetrico che si diceva, con Pechino che apre il suo a intermittenza), ma intanto molte azioni concrete mostrano il tentativo di ridurre la dipendenza dall’estero e anzitutto dall’Occidente. Xi sembra volersi assicurare almeno un’opzione residua di sollevare il ponte levatoio (o meglio una nuova Grande Muraglia) e chiudersi in una sorta di “fortezza Cina”. Pechino sembra vivere, in salsa cinese, una fase isolazionista, di ripiegamento su di sé. Dopo la fase dell’apertura quasi spavalda al mondo, la Repubblica popolare è preoccupata, introversa e sospettosa – come sottolinea nel suo saggio Giada Messetti. Resta da vedere se il sospetto si tramuterà in prudenza o aggressività.
In chiave sistemica, l’infrastruttura globale su cui ha poggiato l’espansione dei commerci trainata dalla crescita cinese e dai consumi americani è ancora funzionante, ma a ritmi rallentati, con catene del valore più corte e con snodi cruciali che rischiano di bloccarsi. In tale contesto, è davvero difficile per tutti – soprattutto per l’Europa – perseguire progetti a medio e lungo termine che richiedono massicci investimenti e regole chiare. A maggior ragione quando l’imperativo della sicurezza energetica scuote modelli industriali un tempo basati sull’import di gas a basso costo dalla Russia e l’export verso la Cina; e quando si deve evitare che la radicale trasformazione dei meccanismi produttivi verso la sostenibilità ambientale creino nuove dipendenze, da Pechino anzitutto.
Abbiamo tutti imparato, sulla nostra pelle, che la diversificazione è l’unica salvezza: vale per i vaccini, i microchip, i pannelli fotovoltaici, il gas naturale, le terre rare. Diversificare non significa, di per sé, isolare una Cina che si sta in parte isolando. Non si tratta neppure di inseguire una visione autarchica per grandi blocchi commerciali, o quantomeno non è questo il “Piano A” (anche a Washington) finché non vi fosse un totale deterioramento dei rapporti diplomatici con Pechino. Ma standard, controlli e garanzie si imporranno sempre più come strumenti necessari per contenere la diplomazia economica coercitiva delle potenze rivali autoritarie, sia in base a criteri ambientali che in base a considerazioni di sicurezza. Per gli europei, in particolare, lo shock energetico imposto dalla guerra in Ucraina lascerà un segno profondo anche in altri settori e verso altri paesi: il vecchio “rischio politico” è nuovamente percepito come un problema centrale.
In conclusione, anche le aziende cinesi faranno parte di un mondo parzialmente “de-globalizzato” ma ancora fortemente integrato: a patto, tuttavia, che evolvano verso modelli produttivi più responsabili e standard più trasparenti. Pechino dovrà chiarire e definire quale ruolo immagina per il suo business nel riequilibrare le filiere globali e un vasto mercato interno.
Da parte occidentale, è bene ricordare che non è comunque nostro interesse bloccare la logistica mondiale, le rotte marittime, le filiere alimentari, gli scambi scientifici, la cooperazione di base in campo sanitario, il coordinamento sulle questioni ambientali. Accorciare le catene del valore e aumentare la sovranità europea in vari campi ha senso, in particolare nelle tecnologie sensibili; ma è un’illusione pensare a operazioni di “reshoring” radicale. Anche se l’ipotesi avanzata dal segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, sul “friend-shoring” – la cooperazione privilegiata tra alleati – offre spazi di manovra e andrà sfruttata, rimarrà comunque una quota di interdipendenza con un mega-mercato come quello cinese. E qui il punto vero riguarda regole del gioco da riscrivere: quanto più Europa e Stati Uniti riusciranno a trovare degli accordi, tanto più si ridurranno gli spazi per la diplomazia coercitiva di Pechino.
* * *
Sta peraltro perdendo peso una fonte di preoccupazione primaria per l’Occidente: l’ipotesi di un saldo asse delle autocrazie – con la Cina ovviamente a fare da potenza-guida – che sostenga un paese come la Russia nel momento della massima difficoltà. Se la concertazione fra potenze non occidentali esiste e cresce nel tempo, i limiti di ipotesi di questo tipo sono emersi dal vertice di Samarcanda di metà settembre, quando la Shanghai Cooperation Organization si è riunita, invitando anche India, Pakistan e Turchia.
Leggi anche: Un messaggio da Samarcanda – per le autocrazie e le democrazie
Un vertice di questo tipo indica che il vecchio ordine globale si sta frammentando, mentre aumenta lo spazio delle medie potenze: lo conferma, ad esempio, l’attivismo diplomatico della Turchia. Ma non nascerà, sull’Ucraina, un fronte del Global South a favore di Mosca: siamo entrati piuttosto in una fase di allineamenti multipli, dove si incrociano accordi con l’Occidente e intese separate. Tutti i partecipanti alla riunione di Samarcanda, a cominciare da Xi, hanno invitato espressamente Putin a porre fine a un conflitto militare fortemente destabilizzante – anche per loro e non solo per l’Europa. L’evento ha messo semmai in evidenza che la Russia, con l’invasione dell’Ucraina, si è infilata in una sua terribile trappola, psicologica, politica e militare; non sarà la Repubblica popolare, che è alle prese con le proprie difficoltà, a sacrificare gli interessi a lungo termine dei cinesi per salvare le sorti di un junior partner molto problematico e poco affidabile.
Il pragmatismo della Cina in questo caso esiste e resiste, unito a un comportamento opportunistico che la porta a sfruttare qualche dividendo potenziale della guerra in Ucraina ma senza perdere di vista ciò che realmente conta per Pechino: l’esito della competizione globale con gli Stati Uniti. Una competizione che, dal punto di vista geopolitico, la Cina si giocherà in Asia, più che alla periferia orientale dell’Europa.
Editoriale del numero 98 di Aspenia