Dall’URSS a Putin, si fa presto a dire impero
Questo articolo è pubblicato sul numero 3-2025 di Aspenia
Prima di constatare che qualcosa sta tornando occorre capire cos’è. La definizione di impero ha ispirato una storiografia pluridecennale che ha contribuito enormemente alla comprensione di come funzionano Stati compositi di grandi dimensioni; realtà non immediatamente comprensibili dal punto di vista di chi era abituato (erroneamente) a considerare come naturale la condizione delle democrazie repubblicane della contemporaneità, almeno nell’Occidente dopo il 1945. E però strada facendo, dopo intere biblioteche di studi, la definizione ha finito per essere applicata a situazioni assai diverse. La parola comprende monopoli commerciali in continenti remoti, relazioni dinastiche precarie, feroci progetti di conquista e sapienti gestioni delle differenze (che hanno alimentato l’equivoco della categoria di impero come sinonimo di tolleranza politica). Commonwealth plurali, monarchie elettive o assolutismi militari. L’aggettivo “informale” ha permesso di estendere ulteriormente il concetto alle relazioni internazionali per descrivere sistemi di alleanze politico–militari diseguali (approvate da parlamenti eletti democraticamente) oppure progetti dichiaratamente anti–imperiali e anti–coloniali come l’Internazionale comunista (il primo partito politico globale, dopo i gesuiti). È stato applicato a organismi sovranazionali oppure a relazioni di dipendenza economica. Con questo criterio anche la Firenze dei banchieri rinascimentali, sede di indubbia potenza economica come la Ginevra della finanza globale, potrebbe essere descritta come una sorta di impero, così come il Terzo Reich o la Società delle Nazioni.
Ciascuna di queste applicazioni definitorie ha un suo fondamento, ma quando una parola è usata per descrivere cose troppo diverse si sente il bisogno di circoscriverne il significato. Se la categoria di impero viene assunta quale chiave di lettura della storia mondiale plurisecolare, se diventa una “forma” perenne, fluida e adattabile, un sistema di “reciprocità asimmetriche” e di “sovranità stratificate” perpetuamente negoziate — in cui rientrano tanto lo stato di diritto asburgico quanto lo sterminio dei dissenzienti, il divieto del commercio privato o le battaglie per i diritti civili, — il concetto di democrazia politica finisce per scomparire o diventare una tappezzeria tra le tante in una storia di sistemi imperiali interdipendenti. Al buio di un concetto di impero dilatato a dismisura, tutti i gatti diventano grigi.
Conviene forse partire dal presupposto che imperi sono gli Stati che si definirono tali, e poi cercare di osservarne traiettorie differenziate, specificità e riemersioni in forme nuove o parziali di continuità antiche. Lo storico della Russia può cercare di contribuire a questa riflessione riconducendola alla concretezza del proprio campo di indagine, con sensibilità per il significato che gli attori attribuiscono alle parole. E cercando poi di capire cosa c’è di nuovo e cosa di antico in quello che oggi anche gli interpreti più indulgenti e a lungo possibilisti chiamano “regime putiniano”.
UNA NAZIONE ANSIOSA E IMPREVEDIBILE. L’Unione Sovietica non finì a causa di una guerra o una rivoluzione, ma la cesura fu accompagnata da due vuoti profondissimi, di idee e di istituzioni. Il divieto costituzionale di un’ideologia guida esprimeva un desiderio di emancipazione dall’unanimismo sovietico, ma mancarono una classe dirigente e una progettualità politica in pectore. Da qui l’atteggiamento di “imitazione” tematizzato da Stephen Holmes e Ivan Krastev: la politica come sforzo di immedesimazione in un “altro” occidentale, seguita dalla delusione, dal risentimento e dall’assunzione di questo altro come antitesi retorica di sé e poi come nemico esistenziale. Nelle ex repubbliche sovietiche – tutt’altro che stabili, dalla Moldavia al Tagikistan – potevano riempire questo vuoto i linguaggi del nazionalismo o dell’anticolonialismo, inevitabilmente un po’ artificiosi come peraltro in tutte le comunità politiche (inclusa la nostra). Nel caso della Federazione russa, nonostante una diplomazia agli inizi persino arrendevole, fin dagli anni Novanta coesistevano invece disorientamento e sete di grandezza.
Più si scava nel dibattito di quel periodo oltre il linguaggio ufficiale (costituzione, elezioni, codici penali, ecc.), più si osserva il brodo ribollente dei discorsi visionari in generi diversi come letteratura o cinema, le diffusissime teorie cospirative, la cultura militare, le riflessioni storiosofiche, più ci si rende conto di uno stato d’animo ansioso e instabile. Un quadro che non favoriva l’accettazione della fine dell’Unione Sovietica come nuovo inizio e come opportunità, all’interno di confini geografici e soprattutto mentali accettati. Non meno, e per certi versi anche più dell’Ucraina, quello della Federazione russa era lo stato nuovo di una nazione “inattesa” e dal destino incerto, piuttosto che la sopravvivenza di un impero eterno.
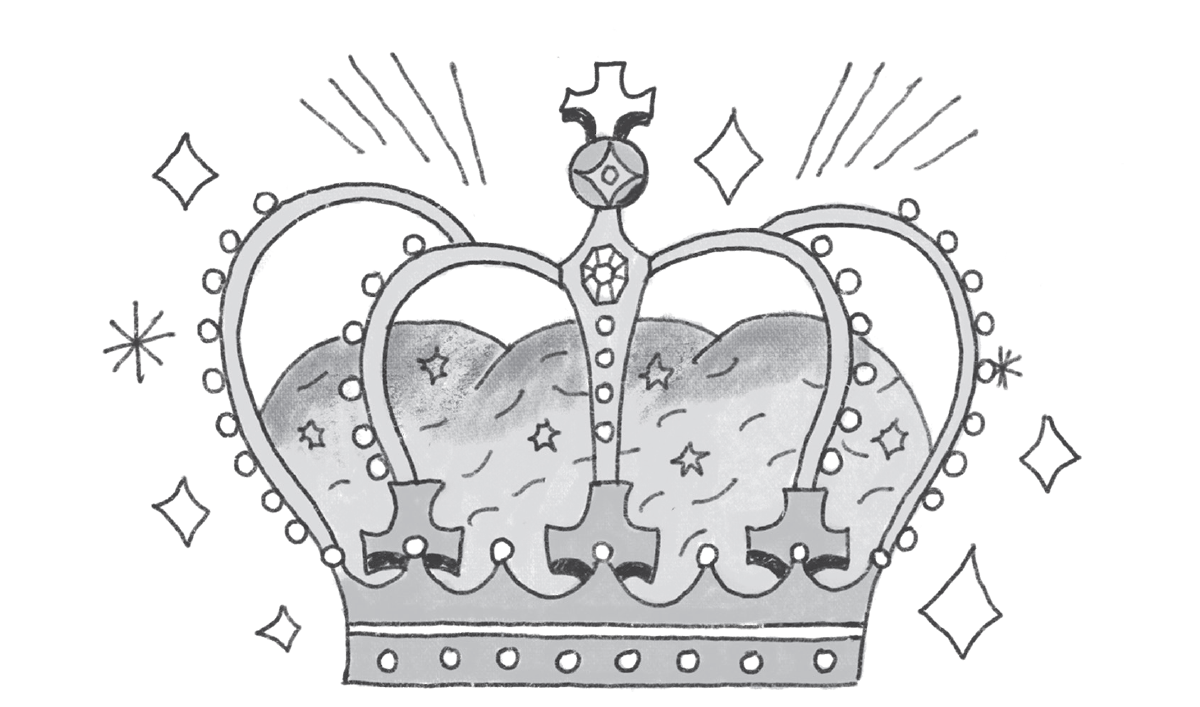
Il vuoto ideologico interagiva con una crisi profondissima delle istituzioni, intese come esercizio quotidiano della governance: contrasto della criminalità, servizi pubblici essenziali, riscossione delle tasse, ecc. Quando il capo della polizia, il magistrato o il politico–imprenditore locali sono al soldo di organizzazioni criminali, o sono essi stessi alla guida di consorzi semi–banditeschi, democrazia diventa una parola vuota. Risulta impossibile l’esercizio della cittadinanza così come il funzionamento del mercato, sia pure in una delle molteplici gradazioni esistenti tra interesse pubblico e privato. Più che dalla diffusione di un generico neoliberismo, la crisi della breve stagione democratica russa, di fatto conclusa già nel 1994, derivò dall’incapacità di costruire le istituzioni dello Stato.
“Verticale del potere” o “stabilità”, le formule retoriche del primo putinismo, avrebbero potuto esprimere una traiettoria costruttiva. L’introduzione di un sistema fiscale, il Codice agrario del 2001 (definizione dei diritti fondiari e poi crescita notevole della produzione cerealicola), l’aumento del numero di magistrati e dei loro salari (per scoraggiare la corruzione, che poi non ha impedito la subordinazione del giudiziario all’esecutivo) potrebbero essere considerati come tasselli esemplificativi di un percorso alternativo. Una direzione ipotetica ma non irrealistica, favorita anche dall’aumento del prezzo delle materie prime: quella cioè di uno Stato semiautoritario accompagnato da una retorica superficialmente e nostalgicamente neosovietica, certo nazionalista, capace però di costruire una architettura istituzionale. All’interno di tale architettura avrebbe potuto svilupparsi – in forme non imitative, come è giusto oltre che necessario sia in qualunque democrazia – una dialettica politica reale (in una società già allora molto più pluralisticamente “normale” e dinamica di come la descrive l’attuale retorica su un genetico “codice di civilizzazione”) e poi l’alternanza al potere di persone e idee. Non è un caso che, dopo gli ultimi anni della perestrojka, una nuova stagione di partecipazione politica abbia seguito il (relativo) miracolo economico russo di inizio millennio e il miglioramento consistente delle condizioni di esistenza che ne è seguito, concretizzandosi nelle proteste per i brogli elettorali del 2011–2012, ma anche nel nazionalismo spontaneo.
DAL SOGNO ALLA GUERRA. Si tratta di una possibilità che non si è realizzata a partire da una svolta che risale già al secondo mandato presidenziale di Vladimir Putin (2004–2008), almeno nei propositi e nei progetti. È il caso però di ricordare come Vladislav Surkov, allora uno degli ispiratori del regime, abbia recentemente descritto quella di oggi come “la Russia che noi sognavamo nel 1999”.
La radicalizzazione ha seguito tre linee tra loro intrecciate che si sono alimentate reciprocamente in modo esplosivo. La prima fu il connubio tra vulnerabilità e personalizzazione del potere. Dirigenti abituati a considerarsi combattenti intenti a salvare la Russia dal baratro, erano persuasi di governare un popolo incapace di intendere e di volere, elettori volubili pronti a votare per qualunque “quinta colonna” o “agente straniero” che li avesse pagati o influenzati. La consapevolezza di una élite frammentata, unita dal ricatto più che dal senso di appartenenza politica e istituzionale, favorì la ricerca di un soggetto personalizzato sovrastante, una figura nuovamente “al di sopra delle opinioni umane” (così nelle lezioni di Michail Speranskij all’erede al trono, 1845), indispensabile per tenere insieme lo Stato. Tale ricerca si è concretizzata nella staffetta Putin–Medvedev per poi essere illustrata dallo slogan di un famoso spot elettorale recente: “noi abbiamo un solo presidente”. Non si trattava, e non si tratta tuttora, di un mediatore super partes, ma dell’accettazione consapevole di un arbitrio sovraistituzionale permanente, necessariamente discrezionale e capace di intimorire, ritenuto indispensabile per assicurare continuità e progresso dello Stato e della nazione.
In secondo luogo, la spazializzazione dell’idea di una rinascita russa dopo la crisi degli anni Novanta portava a considerare la reintegrazione (in qualche forma nuova, da inventare) dell’area post sovietica come un obiettivo non di politica estera, ma esistenziale. Già nel 2005 si esprimeva al massimo livello non tanto una nostalgia post imperiale, quanto piuttosto il rifiuto categorico di accettare la “capacità di esistenza statuale” delle ex repubbliche, la cui nascita Putin per primo, già nel 1991 (insieme a molti altri) considerava l’esito di uno smembramento artificioso. Questo induceva a scorgere nelle tante e diverse “rivoluzioni colorate” non solo sviluppi locali sgradevoli per la diplomazia o la sicurezza, crisi di assestamento in Stati nuovi e confinanti, ma anche una minaccia di contagio destabilizzante e un attentato alla “sovranità” della Russia, così intesa. NATO o non NATO, una simile postura produceva destabilizzazione nello spazio post sovietico.
Infine, la persuasione che “per la sua storia e la sua geografia la Russia è destinata a essere leader mondiale” (Putin, 2013) esprimeva non soltanto volontà di potenza, ma l’ambizione di portare nel mondo un principio nuovo, un’idea alternativa di qualche tipo. La postura filo–occidentale ed europeista di inizio millennio nasceva dalla consapevolezza della propria debolezza. Mirava a veder riconosciuta dagli altri grandi del tempo, in primis Stati Uniti e Germania, lo status di grande attore europeo e mondiale, e conseguentemente la sovranità indiretta sull’area di competenza perduta nel 1991 – uno schema negoziale che si ripete oggi da posizioni di forza nelle trattative con Trump, dal quale si spera di ottenere ciò che l’esercito russo non riesce a conquistare sul campo. La crisi dell’egemonia statunitense dopo il 2008, forse il fattore esogeno più importante di questa evoluzione, alimentò le ambizioni e la ricerca di una differenziazione ideologica (“il liberalismo è obsoleto”).
La sfortuna dell’Ucraina è consistita nel trovarsi non al confine di una deterministica faglia geopolitica, ma all’intersezione di queste linee di radicalizzazione dell’idea di cosa dovrebbe rappresentare la Russia; un progetto politico coltivato con determinazione che non è esagerato definire religiosa. È quindi diventata teatro di una guerra che non è – e non è mai stata – solo una contesa per alcuni territori dall’appartenenza controversa.
Possiamo anche attribuire a questa traiettoria la definizione di un ritorno imperiale, a patto che se ne colgano le specificità: una miscela in verità moderna in cui utopia e Realpolitik sono intrecciate strettamente. Lo spazio “sacro” di Putin (le truppe in ritirata da Kherson riesumarono ed evacuarono in gran segreto la salma di Grigorij Potemkin, l’architetto della conquista settecentesca della Nuova Russia, come una reliquia) è ben diverso da quello “immobiliare” trumpiano, svuotato di ogni significato valoriale e ridotto a trattativa su utilità materiali, reali o presunte.
Nonostante le affinità e la simpatia reciproca, i due negoziatori di Anchorage parlavano lingue diverse. Anche per questo il loro dialogo non poteva produrre una mediazione significativa. La storia ci dirà se la strada imboccata dal regime putiniano, ormai da un ventennio, porterà a un esito autodistruttivo oppure si rivelerà l’esordio di un nuovo ordine mondiale. Giova però ricordare che nella storia russa queste due opzioni non si escludono reciprocamente.
Questo articolo è pubblicato sul numero 3-2025 di Aspenia.
